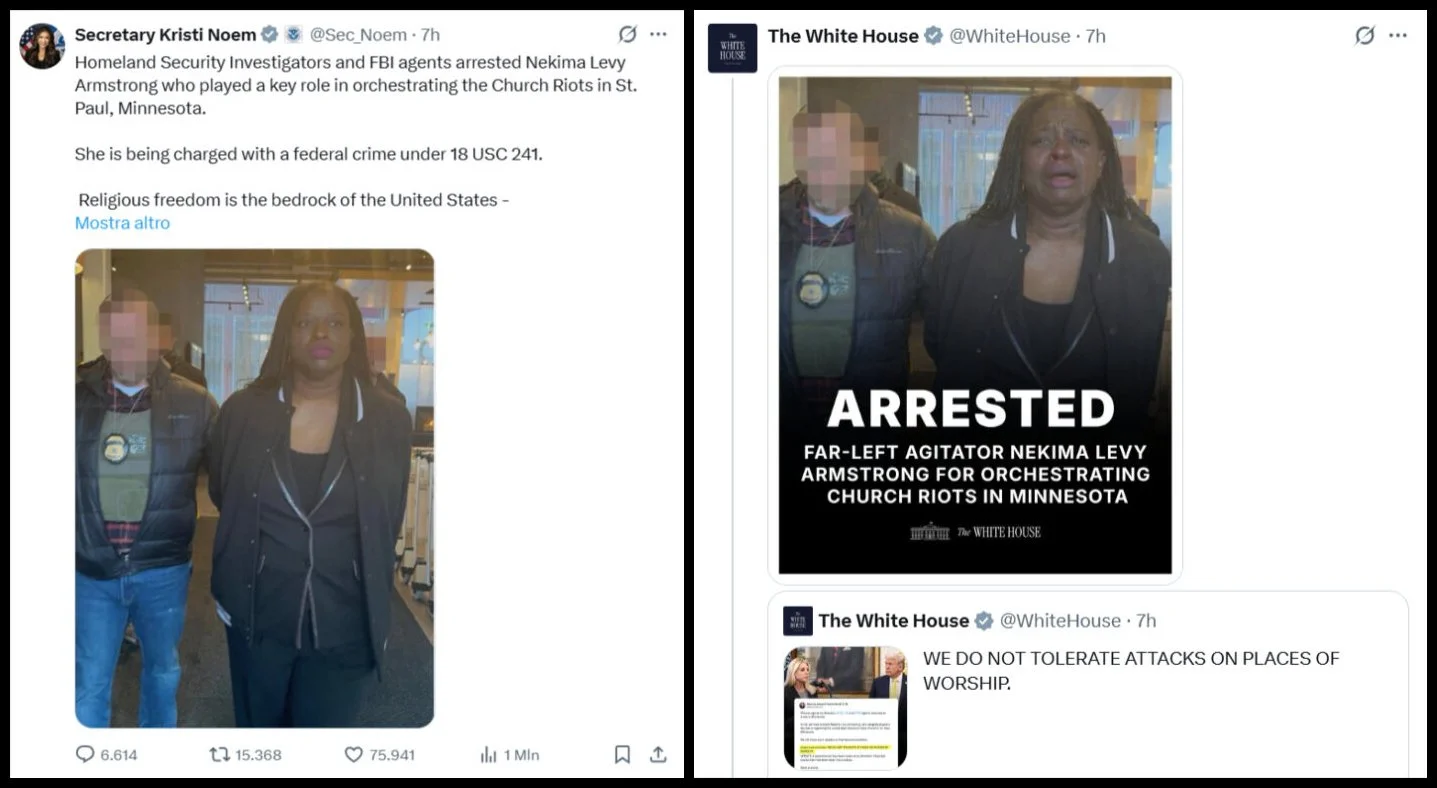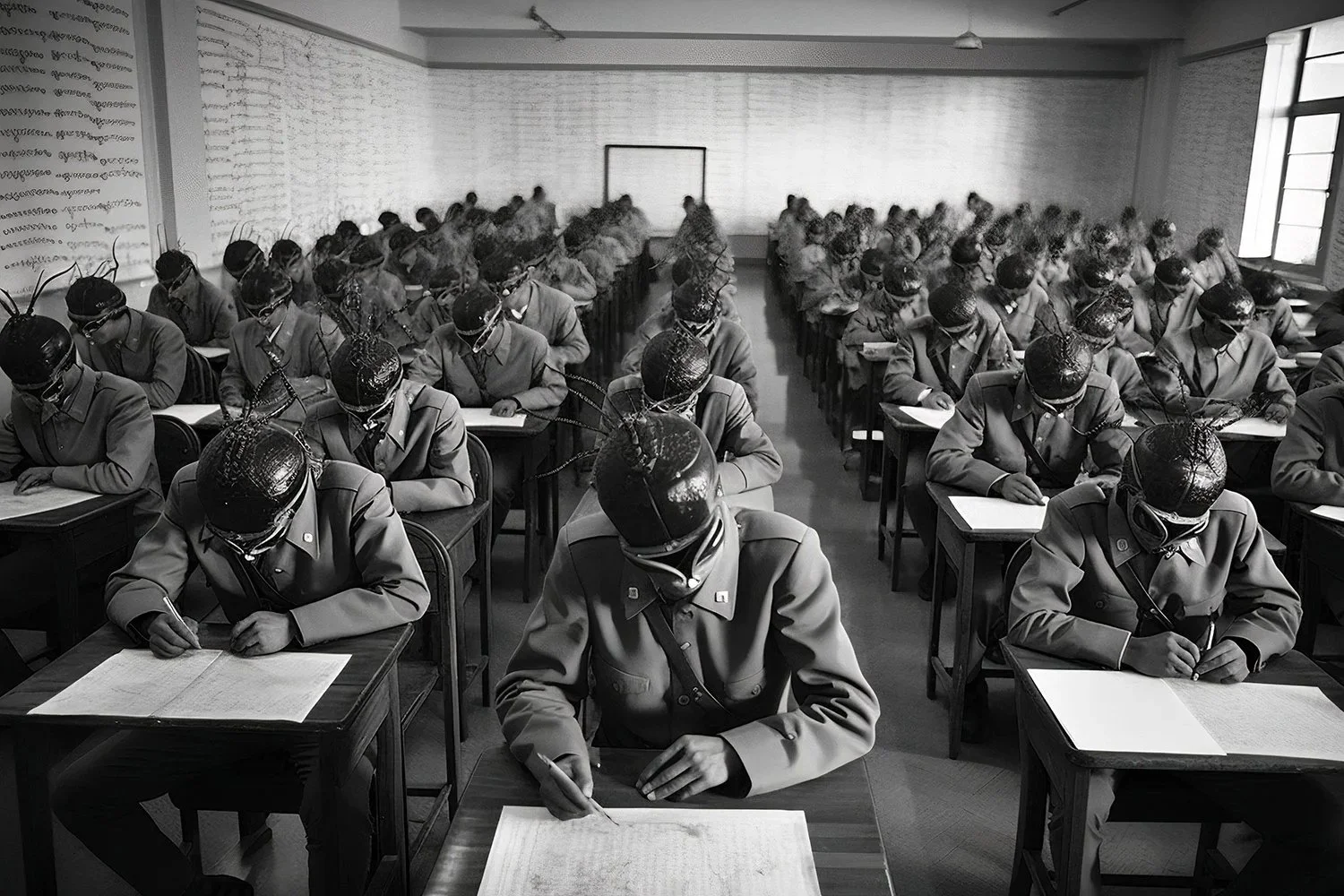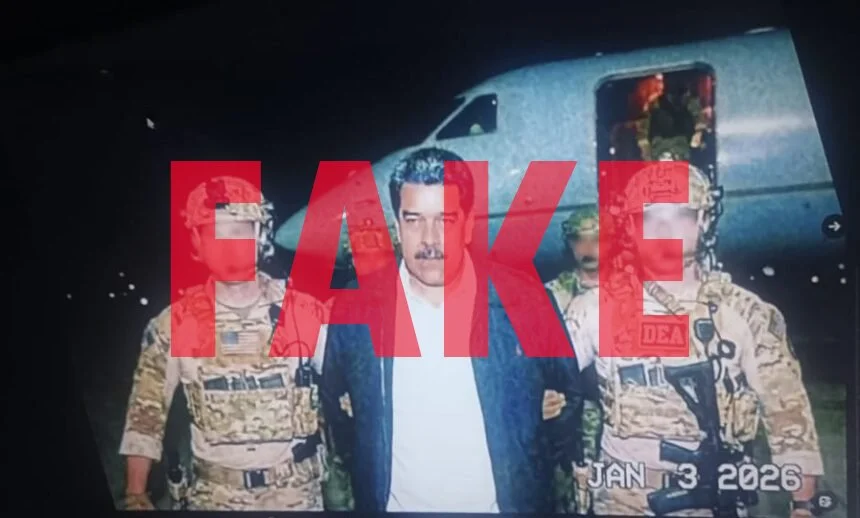Tina Davis aveva 14 anni quando è stata reclutata assieme ad altre 8-9 ragazze per un party a Mar-a-Lago, e le è stato detto “vestiti sexy”. Secondo la madre Sandra Coleman, che l’ha accompagnata, tutte erano molto giovani, a momenti non avevano neanche bisogno del reggiseno.
Quando sono arrivati a Mar-a-Lago a Tina è stato subito dato un bicchiere di champagne. La madre gliel’ha tolto di mano, ma i camerieri continuavano ad offrire. Uomini di mezza età si avvicinano di continuo a Tina, e la madre rispondeva “Buongiorno, sono sua madre.”
Durante una fermata al bagno hanno incrociato Marla Maples, che aveva sposato Trump l’anno prima e che avevano già conosciuto durante il party. Coleman dice che Maples l’ha presa per mano, l’ha guardata negli occhi, e ha detto “Fai tutto il possibile per impedire che quegli uomini si avvicinino a tua figlia, mio marito soprattutto. Proteggila.”
(fonte: The New York Times)
Le dinamiche del potere tendono a ripetersi con regolarità. Uomini ricchi si rivelano consumati dal bisogno di confermare la propria supremazia attraverso il dominio sessuale su ragazze giovanissime, ancora prive di quel carattere e di quella autonomia che rendono le donne adulte meno facili da sottomettere o comunque non completamente annullabili come persone. Il potere sembra quindi desiderare vittime disarmate per compiersi nella sua interezza.
In questo scenario, c’è una figura enigmatica che regolarmente ritorna: quella della moglie che sa.
Spesso anche lei una vittima, ma da tempo non più centrale, a volte giungendo a una convivenza arida e formale, che vive nel palazzo, accanto al mostro, e ne conosce la forma reale.
Marla Maples e Veronica Lario probabilmente un tempo furono attratte dal potere, dalla ricchezza e dal carisma di un uomo e solo in un secondo momento ne hanno scoperto la componente predatoria.
La Lario parlò delle “vergini offerte al drago”, nominando ciò che tutti vedevano ma nessuno voleva riconoscere come tale. Non lo fece per distruggere il sistema (cosa che chi vive dentro il palazzo raramente sceglie di fare) ma per incrinarne il mito. La Maples cercò invece di salvare una ragazzina di 14 anni ormai giunta nella tana del mostro, ma chissà quante altre volte è rimasta in silenzio, osservando il rito compiersi.
Queste donne stanno sul confine tra complicità e resistenza, tra protezione e impotenza, forse in cerca di una redenzione, a volte tardiva e parziale, senza però compiere il passo decisivo.
Questa esitazione, con la complicità della corte intera, consente al mostro di sopravvivere a lungo.