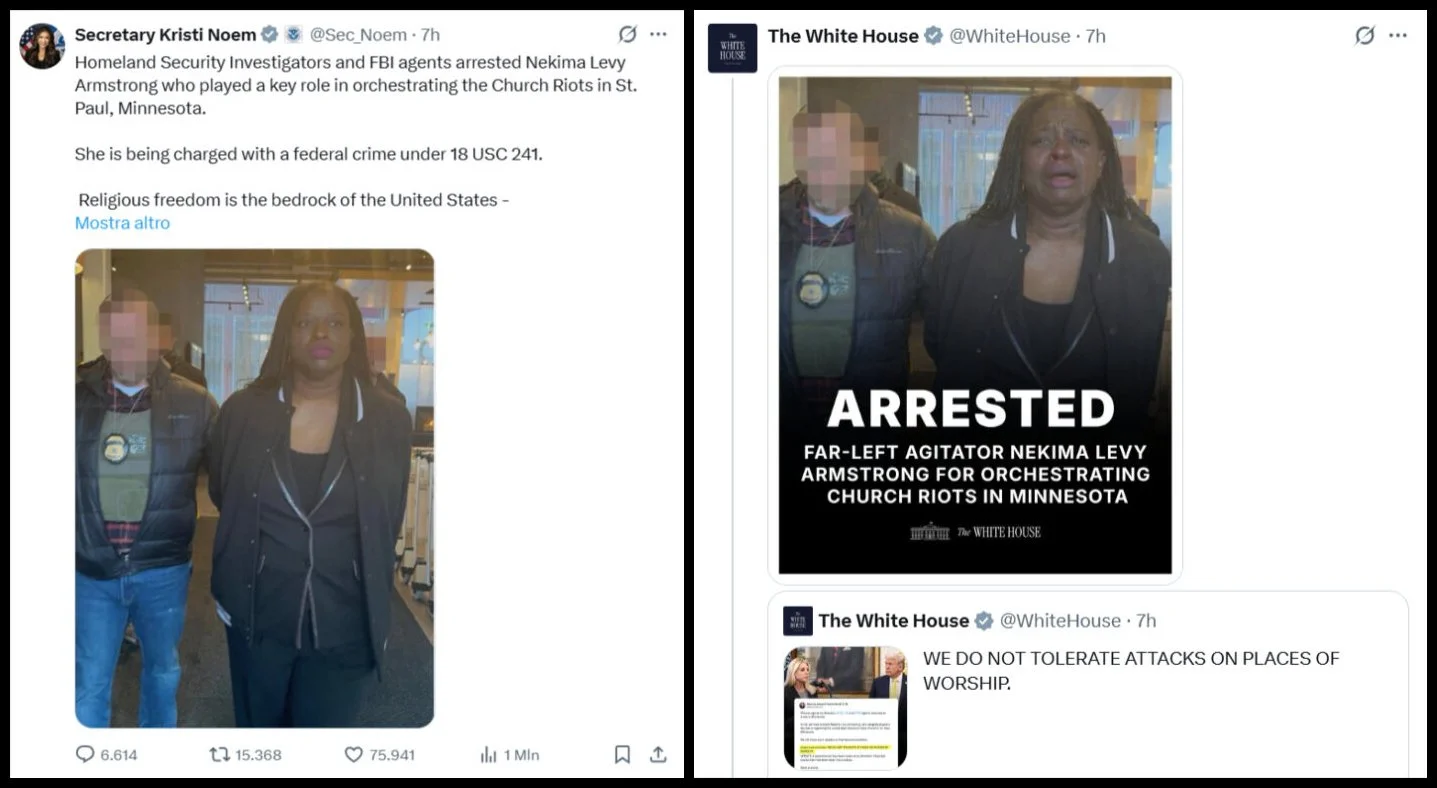SCONFINAMENTI
Esplorazioni visive lungo la Statale 12, da Pisa al Brennero
Progetto ideato da Luca Sorbo
A cura di Luca Monelli e Luca Sorbo
SCONFINAMENTI nasce dalla consapevolezza che la Statale 12 non è una semplice arteria di collegamento, ma una vera e propria spina dorsale storica, geografica e culturale del Centro-Nord Italia.
Una strada antica, di origine medievale, che da Pisa si spinge verso nord attraversando l’Appennino, supera il passo dell’Abetone, scende nella pianura padana, tocca Modena e Mantova, risale verso Verona, Trento, Bolzano e infine raggiunge il Brennero.
Lungo questo tracciato si concentrano quasi tutti i paesaggi possibili del nostro Paese: il mare, la montagna, la pianura, i laghi, le valli alpine e le Dolomiti. Ma soprattutto si incontrano forme diverse di abitare, lavorare, attraversare, resistere e trasformare il territorio.
SCONFINAMENTI è un invito a misurarsi con questa complessità senza ridurla, senza semplificarla, senza cercare scorciatoie visive.
Abbiamo selezionato 17 autori che possiedono già un percorso fotografico maturo, riconoscibile, capace di sostenere una riflessione lunga e profonda. A ciascuno di voi viene affidato un tratto di strada: non come semplice tema, ma come territorio di confronto, di ascolto, di esplorazione critica.
L’obiettivo è costruire, attraverso 20 immagini per autore, una sintesi visiva capace di restituire la stratificazione geografica, sociale, simbolica e umana di quel segmento di Statale 12.
Il riferimento ideale è l’esperienza di Luigi Ghirri e della grande tradizione italiana di ricognizione del territorio: non per imitarne i risultati formali, ma per condividere l’intenzione, il metodo, l’attenzione al reale.
La Statale 12, in questo senso, è quasi l’opposto della Via Emilia: non genera città in sequenza, ma le sfiora, le attraversa, le aggira. È una strada irregolare, discontinua, a tratti marginale, e proprio per questo profondamente contemporanea.
SCONFINAMENTI vuole esaltare le differenze, le fratture, le disomogeneità del percorso, costruendo un racconto corale in cui ogni autore mantiene la propria voce, ma contribuisce a un progetto unitario e ambizioso.
Il progetto prenderà avvio a gennaio 2026 e si concluderà a dicembre 2026.
È prevista una prima fase di mostre locali, lungo il tracciato della Statale 12, per creare attenzione, confronto e restituzione pubblica del lavoro.
A seguire, una mostra collettiva finale in una sede prestigiosa (in corso di individuazione), che riunirà tutti gli autori e i lavori realizzati.
Il progetto si concluderà con la pubblicazione di un libro-catalogo, pensato come esito editoriale definitivo e strumento di memoria.
La strada è stata suddivisa in otto tratti, affidati a due autori ciascuno:
1. Da Pisa a Lucca
2. Da Lucca all’Abetone
3. Dall’Abetone a Modena
4. Da Modena a Mantova
5. Da Mantova a Verona
6. Da Verona a Trento
7. Da Trento a Bolzano
8. Da Bolzano al Brennero
Parallelamente, Raffaele Capasso curerà la ricerca delle fotografie storiche legate alla Statale 12, coinvolgendo i circoli FIAF lungo il percorso, creando un dialogo tra passato e presente, memoria e sguardo contemporaneo.
SCONFINAMENTI è una sfida collettiva.
Richiede tempo, attenzione, responsabilità e visione.
Ma offre in cambio la possibilità di partecipare a un progetto che ambisce a lasciare una traccia reale, culturale e condivisa.
Gli autori coinvolti:
Stefania Adami, Andrea Angelini, Daniela Bazzani, Nazzareno Berton, Sergio Carlesso, Enzo Crispino, Eugenio Fieni, Alessandro Fruzzetti, Enrico Genovesi, Davide Grossi, Daniele Lira, Giulio Montini, Antonella Monzoni, Paola Rossi, Giuliano Reggiani, Filippo Venturi.